«Studenti somari? Sì, ma non è colpa loro», un prof calabrese non ci sta
Pupo critica l’appello dei seicento accademici: è anche colpa loro se la scuola è in declino e i giovani universitari sono semianalfabeti
Una volta si sarebbe parlato di asini o, da Napoli in giù, di ciucci (inclusa la variante siciliana scechi) e di baroni. Oggi si parla di prof e studenti. E i prof restano solo prof anche quando danno del semianalfabeta agli studenti di cui dovrebbero aver cura.
Ma la correttezza politica dei redattori dell’appello choc firmato da 600 docenti universitari, che – dopo aver denunciato le gravi lacune nella lingua italiana dell’attuale generazione di studenti – hanno gettato la croce addosso alle scuole e chiesto il soccorso rosso del ministero, non riesce a camuffare un dato: i denuncianti sono i vertici di quella casta accademica più volte finita sotto i riflettori per le proprie pratiche di potere e per il proprio nepotismo e i denunciati, invece, sono i contribuenti di un sistema universitario tra i più costosi e inefficienti dell’Occidente.
Per questo c’è chi non ci sta e commenta in maniera a dir poco critica l’appello dei pezzi grossi. È il caso di Spartaco Pupo, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università della Calabria (e al riguardo occorre ricordare che tra i firmatari del manifesto ci sono 26 prof calabresi: 23 dell’Unical e 3 della Mediterranea di Reggio Calabria), che tenta di scombinare le carte di un gioco mediatico elaborato a priori in favore dei prof: «Gli asini ci sono, per usare un linguaggio vecchio, brutto e improprio, ma non è colpa loro: è brutto accusare gli studenti, quando le responsabilità stanno altrove».
Ma i contenuti della lettera sono veri?
Certo che lo sono. Lo posso testimoniare nella mia esperienza quotidiana di docente e non vorrei passare per difensore d’ufficio degli studenti e dei loro familiari, sebbene sborsino fior di quattrini in tasse per laureare i propri figli.
Ma qual è allora la cosa che non va?
Che l’analfabetismo di ritorno, già consistente, sia in crescita nel nostro Paese non ci sono dubbi: basta accendere la tv o la radio (che poi era l’ultimo fortino della lingua italiana) per accorgersene. I tg e le principali testate hanno abolito i congiuntivi e spesso molti giornalisti indulgono in un gergo da sms o da chat. Questi dati dovrebbero già farci capire quanto questo problema sia diffuso e che le colpe di questa tragedia non sono solo della scuola.
E di chi, allora?
Il mondo dell’istruzione, se posso usare una figura geometrica, è un cerchio che include tutto: dalle famiglie, dove le persone apprendono i rudimenti del linguaggio e l’approccio alla cultura, alle istituzioni accademiche, che dovrebbero perfezionare e suggellare questi due aspetti. Nelle circonferenze ogni punto è, contemporaneamente, punto di partenza e punto di arrivo. Perciò se qualcosa non funziona, com’è evidente che non funzioni e non abbia funzionato, occorre chiedersi dove e quando si sia rotto questo cerchio.
Già: dove e quando?
Mi permetto di rispondere: nel mondo universitario e dopo il ’68.
Che è successo da allora in avanti?
Alcuni settori del mondo accademico, soprattutto quello umanistico, si sono politicizzati in maniera piuttosto pesante. È una storia nota perché raccontata da molti e non insisto oltre. Però c’è da dire che alla politicizzazione è seguita una perdita della qualità che ha distorto un importante processo a cui il mondo accademico italiano era obbligato: la trasformazione della vecchia università di élite, che comunque aveva prodotto un ceto intellettuale di prim’ordine, in università di massa.
Ma che c’entra questo con l’appello dei seicento?
C’entra: gli studenti impreparati che arrivano oggi all’università sono stati formati (spesso si fa per dire) da professori che si sono laureati nelle nostre università: è il cane che si morde la coda.
Perciò?
Io non contesto la sostanza dell’appello dei seicento colleghi, ci mancherebbe. Ne critico il tono e la tempistica e dico due cose. In primo luogo, affermo che lorsignori si potevano accorgere prima di quel che sta accadendo, perché certi disastri non capitano in un giorno solo. In secondo luogo, stigmatizzo il tono populista di quest’appello, che sfiora la caricatura.
In che senso?
Nel senso che i genitori degli studenti, che spendono fior di tasse, potrebbero, a loro volta e con piena legittimità, scrivere una lettera analoga al ministero e chiedere: “Chi è che ha fatto laureare quei professori che hanno trasformato i nostri figli in asini”?
Ma non è che questi problemi sono l’esito di un mancato adattamento del mondo accademico al mondo reale, che nel frattempo è cambiato?
Questa osservazione potrebbe valere ovunque meno che in Italia, perché da noi hanno operato anche alcuni pregiudizi ideologici, trasformatisi in complessi. Primi tra tutti l’oicofobia e l’esterofilia, che è l’altra facciata di questa brutta medaglia.
Qualcosa di preordinato, quindi…
Non saprei dire fino a che punto. Pertanto mi limito a osservare i fatti. Innanzitutto, noto l’eccessiva invadenza del gergo anglosassone anche nell’ambito accademico. Non parlo del settore delle scienze sperimentali, dove il predominio della lingua inglese è il riflesso di rapporti di forza obiettivi per cui il mondo anglosassone è predominante, ma di altri settori, in cui l’abuso delle lingue straniere e dei forestierismi si poteva evitare. Mi riferisco specialmente al nostro mondo umanistico, dove la cultura (e quindi la lingua) italiana ha subito una progressiva emarginazione.
Non è una polemica nuova. Però occorrerebbero prove più solide per queste affermazioni.
Alcuni fatti sono evidenti. Per esempio, la classe accademica, che solo oggi si lamenta, fino all’altro ieri si è abbeverata agli insegnamenti di professori come Tullio De Mauro, che, dopo averci per una vita invitato a privilegiare i dialetti, solo qualche mese prima di morire si è messo a denunciare l’ignoranza della lingua italiana dilagante tra i nostri giovani. Ma dirò di più: la nostra è una università figlia di intellettuali contagiati dalla oicofobia (letteralmente vuol dire paura della propria casa), un fenomeno che colpisce soprattutto la classe intellettuale italiana ed europea e che porta al disprezzo della propria cultura e di tutto ciò che ha a che fare con il retaggio identitario della propria nazione, ad iniziare proprio dalla lingua.
Ci sono dei casi specifici?
Sin dal 1965, l’anno del suo Scrittori e popolo, Alberto Asor Rosa non ha mai smesso di prendersela con gli intellettuali nazional-popolari, bollandoli di provincialismo, conservatorismo e accusandoli di essere l’incarnazione di una cultura paesana, piccolo borghese. Si ricorderanno il suo feroce attacco a Francesco De Sanctis, reo, a suo dire, di aver scritto una storia della letteratura che celebrava la civiltà italiana moderna, e le sue denunce contro i “ridicoli i soprassalti nazionalistici” di cui la cultura letteraria è stata coinvolta. Ancora nel 2009, Asor Rosa pensò di convertire una normale storia della letteratura italiana in una Storia europea della letteratura italiana, come recita il titolo della sua ultima opera, escludendo deliberatamente ogni riferimento all’italianità.
Ma in questa critica non c’è un forte richiamo nostalgico?
Assolutamente no. Nessun riferimento a certi atteggiamenti caricaturali delle nostre precedenti classi dirigenti. Però mi limito a notare che gli italiani, costretti da una pressione scolastico-mediatica senza precedenti ad ingurgitare e usare forestierismi a ogni piè sospinto, sono anche agli ultimi posti per quel che riguarda la padronanza delle lingue straniere. Morale della favola: chi non conosce la propria lingua non può parlare bene neppure quelle altrui. Perciò non scandalizziamoci troppo e, soprattutto, non prendiamocela troppo con gli studenti, che sono l’anello più debole di questa catena fragile, né con la scuola di oggi, che è il prodotto dell’università dell’immediato ieri. La lettera dei seicento colleghi mi sta bene, perché denuncia un problema reale, ripeto. Peccato solo che non sia stata preceduta da un esame di coscienza: sarebbe stata più credibile.
(a cura di Saverio Paletta)
Per saperne di più:
L’appello dei seicento accademici
L’appello dei docenti calabresi
12,135 total views, 2 views today


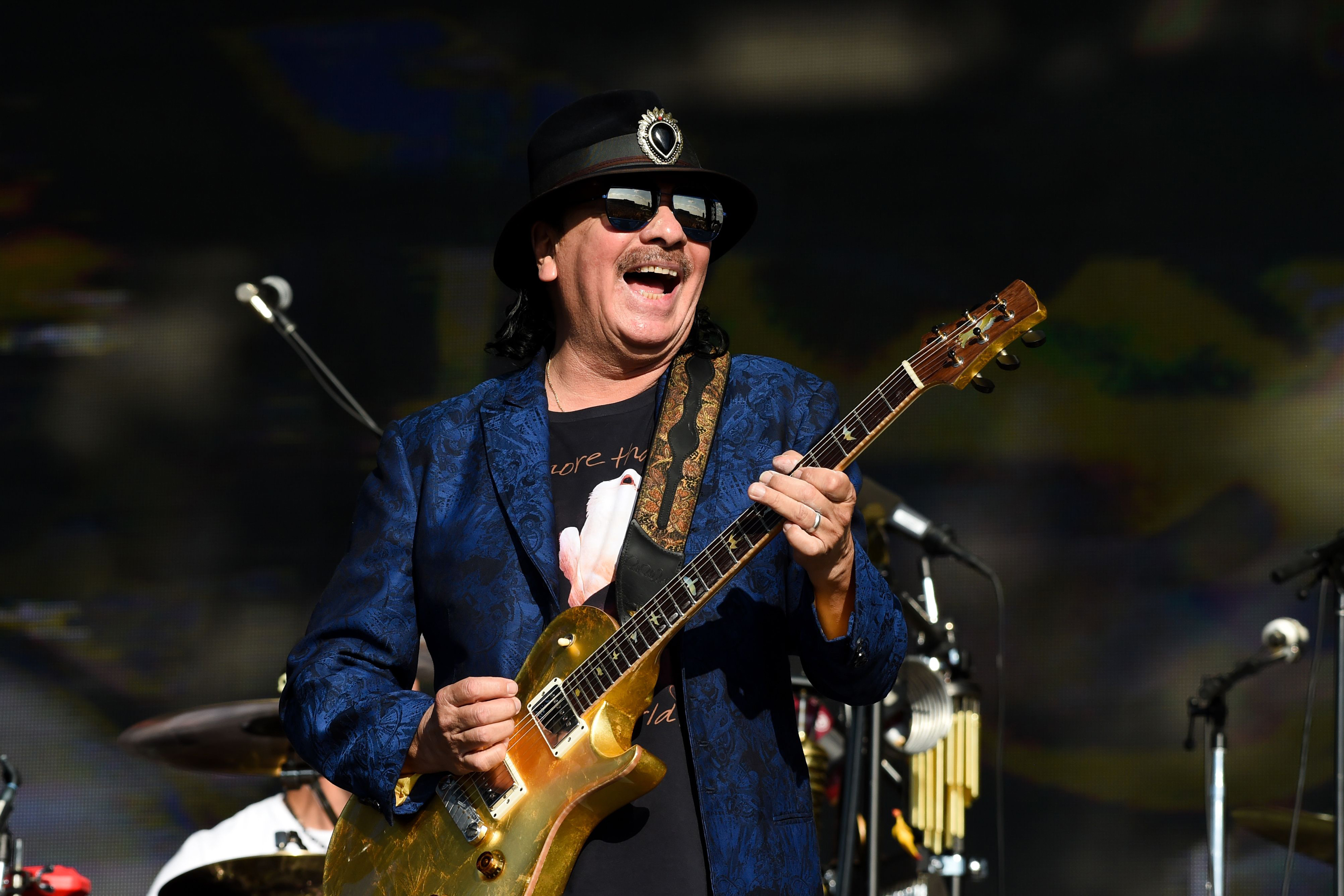

Comments