Slow Journalism, l’informazione del futuro oltre il caos della rete
Come salvare il giornalismo nell’era della disinformazione di massa propagata nel web? Alberto Puliafito e Daniele Nalbone provano a fornire alcune risposte importanti nel loro libro
Alcune cose le sappiamo già: la stampa è in crisi nera, la tv tiene ancora, ma più per l’atavico conservatorismo di intere fasce della popolazione che per la bontà del mezzo, e la radio è prossima alla decozione.
Sopravvivono le nicchie in tutti gli ambiti. Ma le nicchie non sono i media. Soprattutto, non chiudono il sistema dell’informazione e non ne colmano le lacune finanziarie: non generano business, se non di tipo settoriale e spesso con finalità e mezzi piuttosto ambigui (si pensi al cosiddetto brand journalism).
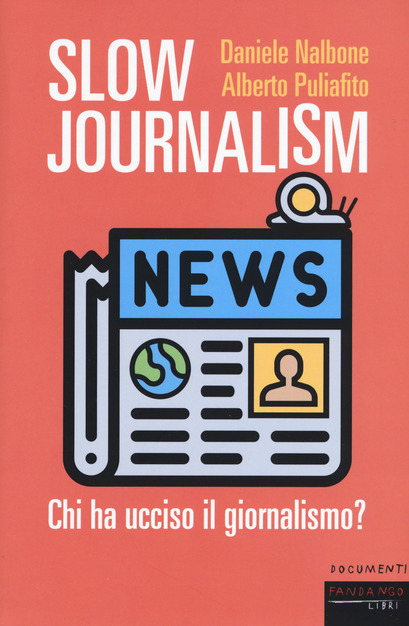
Il giornalismo tradizionale è morto? Forse no, ma di sicuro vive una profonda agonia, ben descritta da Alberto Puliafito e Daniele Nalbone nel loro Slow Journalism. Chi ha ucciso il giornalismo? (Fandango Libri, Roma 2019).
Prima di procedere, è doveroso dire che i due autori sono più che addetti ai lavori. Nalbone, ad esempio, è uno che ha attraversato il confine tra la carta stampata nel momento della sua crisi e il web, perché ha fatto in tempo a esordire con Liberazione, quando la web revolution era agli esordi, e poi si è dato alla rete e ai libri.

Non è da meno Puliafito, che vanta un curriculum chilometrico e un po’ disordinato: dirige Slow News, ha diretto Blogo.it e fondato Tvblog e fa il superconsulente dopo una lunga e a tratti traumatica esperienza nel giornalismo online. E non è un caso che Puliafito riprenda in Slow Journalism non poche intuizioni del suo recente e fortunato Dcm. Dal giornalismo al Digital Content Management (Centro di Documentazione Giornalistica, Roma, seconda edizione 2017), prezioso manuale per tutti quelli che – per curiosità, vocazione e necessità -vogliono districarsi nel giornalismo online.
Torniamo all’agonia, che somiglia a un’ecatombe. Da circa dieci anni la maggior parte dei giornalisti balla sul Titanic: le vendite crollano e quindi i giornali chiudono o si trasformano, esibendo in entrambi i casi forme inquietanti di declino. Calano le audience tradizionali e, quel che è peggio, vanno a picco gli introiti pubblicitari.

In tutto questo, l’informazione online subisce un paradosso apparente: cresce nei numeri ma cala nei fatturati, con conseguenze pesantissime: redazioni chiuse e licenziamenti di massa. Ma questo declino non riguarda solo i giornalisti, costretti a scegliere nel migliore dei casi tra la sottoccupazione (e i relativi compensi da fame) e l’abbandono. Riguarda anche il pubblico, perché la contropartita del processo è la concentrazione editoriale, che riduce il pluralismo, caratteristica vitale dell’informazione.
E allora, si chiedono i due autori, «Chi è il colpevole di tutto questo, se c’è un colpevole?».

La lista degli indiziati è lunga:
«A seconda dei momenti storici ce n’è uno diverso. Oggi l’assassino è Facebook. Prima era Google. Prima ancora è stato Internet. È stata la televisione, che aveva già ucciso il cinema. E più in generale è colpa del video, che aveva ucciso la radio. E poi, naturalmente, è colpa delle persone che sono sempre più stupide: per questo non comprano più i giornali».
Ma questo processo indiziario è insufficiente e sa non poco di scaricabarile.
Infatti: «È sempre colpa di qualcun altro. La causa viene dal freddo, là fuori. La causa è sempre esogena».
Purtroppo, o per fortuna, non c’è una sola causa, ma, spiegano ancora Puliafito e Nalbone, ci sono molte concause, che «sono da ricercarsi anche all’interno del giornalismo stesso».

Slow Journalism è una caccia al colpevole, ma allo stesso tempo, una guida alla ricerca di alternative praticabili all’attuale sistema di informazione, che oscilla tra un mainstream sempre più traballante e nicchie sempre più blindate.
Infatti, ciò che è andato in crisi non è il giornalismo inteso come disciplina, che continuerà a esistere e ad accrescere la sua importanza perché chiamato a chiarire i meccanismi di una società sempre più complessa. È andato in crisi il modello tradizionale di business, che produceva valore economico e reddito perché si reggeva sulle posizioni di oligopolio garantite dalla scarsità delle piattaforme: i sistemi di stampa cartacea e le frequenze radio-televisive. I prezzi che gli utenti dovevano pagare per accedere all’informazione e le tariffe pubblicitarie erano determinati da questa scarsità, che assicurava rendite non indifferenti agli addetti ai lavori, specializzati e non, che gestivano i media a vario titolo.
Come già accennato sopra, il web ha messo in crisi questo sistema e mette in crisi anche la stessa informazione online, finché questa resterà ancorata ai vecchi modelli finanziari. Al riguardo, la crisi superveloce, consumatasi in pochi anni, di molte importanti testate online è più che eloquente: il calo degli introiti pubblicitari ha reso necessari tagli sanguinosi in chi ha provato ad agire secondo le regole tradizionali ha fatto emergere pratiche editoriali a dir poco scorrette.
Queste vanno dalla riduzione drastica dei compensi ai giornalisti, la cui maggiore forma di contrattualizzazione è costituita dai famigerati contratti Uspi-Fnsi che tagliano i salari nel tentativo di salvaguardare la contribuzione. Il resto è una catastrofe: si viene pagati al rigo, come nei vecchi giornali di carta, ma con meccanismi di cottimo decisamente più massacranti, di cui Puliafito fa un resoconto puntualissimo.

E c’è di peggio: i meccanismi di marketing della rete hanno legittimato le strategie acchiappaclic, con tutte le inevitabili distorsioni che ne conseguono: titoli e immagini fuorvianti, diffusione di fake news, abbandono di ogni minima remora deontologica, perché l’importante è quantificare, molto più che in tv e in radio.
Il tutto a scapito di due elementi fortemente legati: sostenibilità per chi produce e consuma informazione e qualità dell’informazione stessa.
Un circolo vizioso al quale, spiegano bene i due autori, non si sottraggono neppure alcune novità editoriali strombazzate in pompa magna, ad esempio Open, il giornale-app fondato da Enrico Mentana che dopo circa un anno di vita denuncia forti criticità.
Ma non è solo un problema di modelli aziendali prossimi alla decozione: il web, in seguito soprattutto all’affermazione dei social, ha comportato anche una forte disintermediazione, grazie alla quale il ruolo tradizionale dei media giornalistici si è trasformato radicalmente.
Da un lato, infatti, la vecchia routine professionale è diventata quasi superflua per molte categorie di notizie (si pensi ai sinistri stradali, alla politica spicciola o alla cronaca nera), dall’altro, non è da sottovalutare il peso dei blogger, non pochi dei quali, a differenza della stragrande maggioranza dei giornalisti, sono specialisti negli argomenti che trattano.
È chiaro, allora, che il giornalismo deve adattarsi per sopravvivere al tracollo dei giornali. Già: le crisi possono anche essere opportunità di rigenerazione per chi è in grado di capire gli eventi e orientarsi di conseguenza per tempo.
Ma, ecco il punto, come? E, inoltre, esistono già dei modelli alternativi e praticabili? Puliafito e Naldone non hanno dubbi: lo Slow Journalism forse non sarà quella grande rivoluzione, ma di sicuro è, se ben approcciato e praticato, la disciplina di frontiera che può consentire la nascita di un nuovo modo di fare informazione.

Un nuovo modo di cui si sentiva il bisogno da prima che il web entrasse di prepotenza nelle vite di quasi tutti per restarci, perché a leggere a fondo il libro di questi due maestri dell’informazione, si capiscono bene due cose.
Innanzitutto il declino dei media tradizionali è dovuto a vizi endogeni (i giornalisti di carta, per dirne una, definiscono bufale quelle che oggi sono chiamate fake news ed è quasi superfluo ricordare che i grandi quotidiani e le tv hanno lanciato bufale a piene mani e a più riprese).
In seconda battuta, le situazioni di degrado professionale e le pratiche scorrette provengono tutte dal vecchio mondo dei media: si pensi ai titoli sensazionalistici, alle distorsioni dovute alla caccia all’audience e alla concorrenza feroce tra le testate, che generava gare a chi le sparava più grosse.
Internet ha solo accelerato il processo, perché ha offerto piattaforme alternative a chi desidera fare informazione. Perciò accusarlo di aver ucciso il giornalismo significa confondere il becchino o il medico che pratica l’eutanasia con il sicario.

E veniamo alle alternative. Slow senz’altro significa lento e già questa definizione suona provocatoria nei confronti delle pratiche fast e spesso a bassa qualità di molta informazione contemporanea. Ma slow indica anche uno stile di vita orientato alla qualità e, meglio ripeterlo, alla sostenibilità. Qualità e sostenibilità nello Slow Journalism significano: rispetto del giornalista e del fruitore dell’informazione, capacità di approfondire, rinuncia alla corsa alle breaking news e alle pratiche da tabloid, etica e deontologia, compensi equi.
Ed è qui che si gioca la partita futura, non solo economica, del giornalismo inteso come disciplina. I due autori intravedono già il futuro auspicabile in alcune esperienze europee e non solo: il web magazine olandese The Correspondent, il trimestrale britannico (più sito web) Delayed Gratification, il danese Zetland, l’italiano Valigia Blu. Tutti tentativi apprezzabilissimi di fare informazione in maniera inclusiva con modelli di business alternativi a quello finora dominante (e declinante), ad esempio col ricorso massiccio (e funzionante) al crowfunding e con la ricerca di mezzi nuovi (la fondazione al posto dell’impresa tradizionale).
Nulla è perfetto, ci mancherebbe, e la strada è ancora lunga. Ma queste iniziative la indicano benissimo. Slow Journalism, a tal proposito, è più che un libro-manifesto: è una vera e propria guida a questo nuovo modo di fare informazione e contribuire a un’opinione pubblica più consapevole e ricca.
Da leggere, sia per gli addetti ai lavori sia per gli appassionati: entrambi ne ricaveranno spunti preziosi.
Per saperne di più:
37,776 total views, 2 views today



Comments